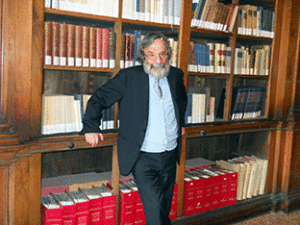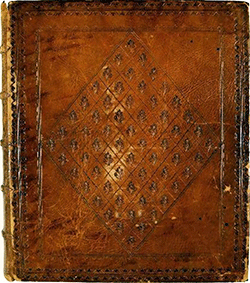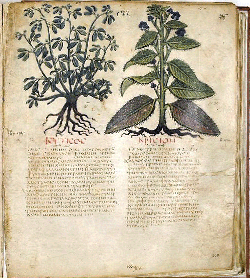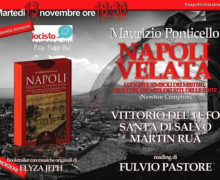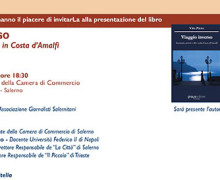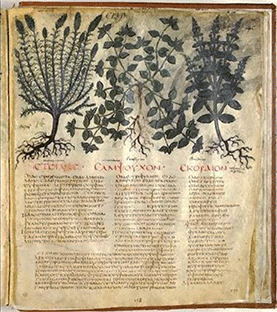
Il libro più raro è custodito a Napoli
È conservato alla Biblioteca nazionale di Napoli quello che è considerato un testimone fondamentale della cultura medica greco-romana tra la fine del VI e gli inizi del VII secolo dopo Cristo. Si tratta del “De materia medica”, un erbario realizzato su pergamena in pagine miniate, opera di Dioscoride Pedanio, medico greco del I secolo dopo Cristo, originario di Anazarbo in Asia Minore. È una sorta di manuale di medicina e di farmacia, organizzato in schede, ciascuna delle quali ha come titolo il nome della singola pianta, vivacemente illustrata, seguito da un commento che ne descrive habitat, proprietà e uso terapeutico. Il manoscritto greco, conosciuto anche come il “Dioscurides Neapolitanus”, è una copia del VI secolo dopo Cristo, realizzata probabilmente in ambiente ravennate. «Si tratta di uno dei manoscritti più preziosi che conserviamo. – spiega Mauro Giancaspro, direttore della Biblioteca nazionale di Napoli – È un codice, termine con cui indichiamo i manoscritti che si fermano all’invenzione della stampa a caratteri mobili nel 1452, che già a suo tempo doveva avere grande valore. Sarebbe, infatti, stato donato alla principessa Giuliana Anicia, figlia dell’imperatore d’Occidente».
Un codice reso ancor più interessante dall’aver superato indenne svariate traversie che lo avrebbero portato dapprima nella biblioteca dell’umanista Antonio Seripando, fratello del cardinale Girolamo, quel generale degli Agostiniani tra i protagonisti del Concilio di Trento. Il manoscritto pergamenaceo, a Napoli già dal primo ventennio del Cinquecento, fu quindi conservato presso il convento agostiniano di San Giovanni a Carbonara, per essere, in seguito portato in Austria, per voler di Carlo VI d’Asburgo, nel 1718, insieme ad altri codici di notevole pregio. «Il Dioscoride ci è stato restituito solo nel 1919 come bottino di guerra. – aggiunge Giancaspro – Vinta la Prima guerra mondiale, l’Italia ottenne, infatti, con il trattato di Saint Germain, la restituzione dei manoscritti trafugati, denominati ex Vindobonensi dal nome latino della città austriaca».
Dopo una breve sosta nella Biblioteca Marciana di Venezia, l’erbario di Dioscoride e gli altri ex viennesi rientrarono definitivamente nella Biblioteca nazionale di Napoli, il 7 giugno 1923, periodo in cui la sede di quest’ultima fu trasferita dal Palazzo degli studi, l’attuale Museo archeologico nazionale, a Palazzo reale, in piazza del Plebiscito. Un manoscritto senza dubbio di notevole pregio dal punto di vista culturale, ma anche di grande valore economico. «Alla fine degli Anni Novanta, in occasione di una mostra per il “Bimillenario di Cristo”, il Dioscoride è stato esposto a Montecassino. Essendo quindi andato in prestito a un’altra biblioteca, il manoscritto è stato assicurato per circa tre miliardi delle vecchie lire. – ha spiegatoGiancaspro – Si tratta di prezzi fuori mercato, così come molto elevati sono anche quelli delle copie facsimilari. Di recente, ne è stata realizzata una dalla casa editrice “Aboca”, che ripubblica l’opera riproducendo le tavole pergamenate con tutte le erbe, alcune delle quali oggi non più rintracciabili in natura».
Il facsimile, che sarà presentato il 6 giugno alla Biblioteca nazionale, è accompagnato dalla traduzione del testo greco, da schede critiche e tavole botaniche moderne, poste a confronto con le conoscenze dioscoridee. Il “De materia medica” è di sicuro tra le opere più preziose conservate nella Biblioteca napoletana, – terza in Italia dopo Firenze e Roma – ma non è l’unica. Nelle magiche stanze di Palazzo reale alberga anche un autografo di San Tommaso. «Si tratta di appunti presi alle lezioni di Alberto Magno. – spiega il direttore – Conosciamo quindi il contenuto, ma non riusciamo a decifrarli in quanto San Tommaso, per guadagnare spazio e tempo, ha usato un suo sistema stenografico, ancora oggi non decodificato».
A rendere ancor più prezioso il patrimonio della Biblioteca partenopea concorrono poi degli autografi di Leopardi, tra i quali “A Silvia” del 1828, e alcuni manoscritti composti subito dopo l’invenzione della stampa a caratteri mobili. «L’ultima fase dei manoscritti miniati più spettacolari si ha proprio dopo il 1452. – aggiunge il direttore – I primi libri a stampa, detti incunaboli, erano tutti bianchi, seriali, privi della possibilità di personalizzare propria dei codici. Nella Biblioteca, conserviamo un manoscritto farnese, della seconda metà del XV secolo, chiamato “La Flora”. Si tratta di un libro d’ore, ovvero di un libro di preghiere ad appannaggio delle nobildonne italiane, prezioso sia da un punto di vista bibliologico, che artistico. È realizzato su un tipo di pergamena particolare, chiamata velino, ottenuta da pelli di vitellini mai nati. Ogni pagina è miniata con scene del vangelo, della vita di Cristo. E quando non presenta miniature, è impreziosita da decorazioni floreali. Anche in questo caso sono state realizzate copie facsimilari che valgono svariate migliaia di euro».
Si tratta di opere di estrema rarità ed elevato valore artistico ed economico, capaci però di suscitare anche profonde emozioni. «Se pensiamo ai papiri ercolanesi conservati nella Biblioteca, siamo di fronte a manoscritti, che sigillati dall’eruzione del Vesuvio del 79 dopo Cristo, non sono transitati attraverso la tradizione manoscritta medioevale. – aggiunge Giancaspro – Si tratta per lo più di opere che erano note solo per il loro titolo, o per citazioni indirette. E’ una grande emozione trovarsi tra le mani, per esempio, il “De natura” di Epicuro, che risale al III-II secolo avanti Cristo». Opere di grande valore di cui è lecito chiedersi quale sarà il futuro in un’epoca in cui domina la tecnologia. Parte di loro sono già state digitalizzate, è il caso, ad esempio, delDioscoride e dei Canti di Leopardi, altre lo saranno a breve grazie anche a un progetto in collaborazione con Google, che prevede per l’appunto la digitalizzazione e la successiva messa in rete dei testi. Eppure nonostante il ricorso sempre più frequente agli strumenti tecnologici per la lettura, la Biblioteca partenopea continua a esercitare grande fascino. Lo testimoniano i numerosi frequentatori delle stanze di Palazzo reale, un tempo adibite ad Appartamento delle feste. «Sono centinaia i giovani che ogni giorno affollano i saloni della Biblioteca. – commenta il direttore – Ragazzi che, nell’allora Salone da ballo, mostrano di sentirsi a proprio agio, studiano, leggono, socializzano e si innamorano». Perché è vero che il computer ed internet assicurano rapidità, permettendo con un semplice gesto di visionare testi anche millenari, ma proprio l’estrema rapidità «…può condurre a perdere il senso del bello e del piacere. La lettura dovrebbe dare emozioni e quella sul cartaceo – conclude Giancaspro – è una lettura fatta per il piacere».
Vanessa Pierattini
Pubblicato il 25 settembre 2013 – Rubrica: Storia